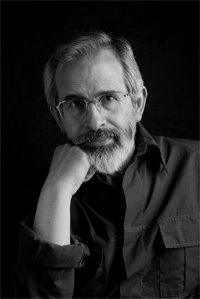Libro utile e interessante per conoscere e capire le
motivazioni, specialmente economiche, che portarono al crollo e alla fine del
Regno delle Due Sicilie. E' il tentativo, dice Panarese nella introduzione, di
scrivere una controstoria, lontana dalla storiografia paludata e retorica,
molto presente nel panorama culturale, nei libri scolastici e testi
universitari, del nostro Paese. Una qualche contraddizione però la si riscontra
tra la definizione di “fenomeno negativo” del brigantaggio presente
nella introduzione e le affermazioni poste all’inizio del capitolo undicesimo,
dedicato appunto
al brigantaggio, quando si afferma: «La reazione contadina contro le
privatizzazioni degenera in brigantaggio. E proprio da qui che bisogna partire
se si vuole comprendere la natura del brigantaggio e non considerarlo
semplicemente un fenomeno criminale».
Il libro si compone di undici capitoli che
trattano dei problemi dell’economia napoletana alla vigilia dell’unificazione,
della classe dirigente meridionale nella crisi dello Stato borbonico,
dell’unione dei Moderati a Napoli e nel Mezzogiorno, della (cosiddetta)
liberazione del Mezzogiorno da parte dei piemontesi, della funzione del
Piemonte nel (cosiddetto) Risorgimento italiano, del mercato italiano
capitalistico, della colonizzazione del Mezzogiorno da parte del capitale
tosco-padano, del Banco delle Due Sicilie, del brigantaggio postunitario inteso
come guerra civile e sociale.
Qui mi limiterò a presentare l’ultimo
capitolo che verte sul brigantaggio postunitario.
L’abolizione della feudalità, promulgata nel
1806, non apportò nessun vantaggio e nessun utile ai contadini, che poveri
erano e ancora più poveri divennero. Quella legislazione del Decennio francese
contribuì invece a rafforzare nobili e borghesi, che ricchi già erano. Lo stato
di miseria esasperò e fece nascere nei contadini un profondo odio che sfociò
nel 1806 in vasti fenomeni di insorgenza e poi nel 1860 nella lotta armata
contro il nuovo Stato unitario. Ai contadini nel giro di pochi anni fu negato
l’esercizio degli usi civici sulle terre che nobili e borghesi usurparono
trasformando il possesso in proprietà. L’uso civico consentiva caccia, pascolo,
legnatico, semina su terreni di proprietà comunale o anche di terzi. La perdita
degli usi civici, non sostituiti dalla quotizzazione delle terre, influì
negativamente sulle condizioni economiche dei contadini e ha fatto sparire la
piccola proprietà contadina nelle campagne dell’antico Regno di Napoli. I
contadini furono costretti a ricorrere ai “galantuomini” per prestiti che non
si riusciva ad estinguere. Oltre la terra, ai contadini veniva sottratta dai
creditori anche la casa. A loro non rimaneva più nulla, se non la rivolta
sociale che esplose violenta «in quegli anni, che vanno inquadrati in questo
mosaico complessivo che è, al tempo stesso, economico, sociale, politico».
In una situazione così delicata, scrive
Panarese, il popolo basso, quello costituito dai contadini e dai cafoni, dai
pastori e dai guardiani delle pecore, dagli artigiani e dalla povera gente, non
ha altra soluzione che accettare come propria bandiera, quella dei Borbone.
A capo dei briganti insorgenti furono posti
valenti condottieri: Carmine Crocco, Eustachio Fasano, Luigi Alonzi detto
Chiavone, il sergente Pasquale Romano, Cosimo Giordano, i fratelli La Gala, il
legittimista spagnolo Josè Borges, e molti altri.
Nel 1862 fu costituita una commissione
d’inchiesta sul brigantaggio, che visitò diverse località del Sud ed ascoltò
molti che in qualche modo erano impegnati contro il brigantaggio, ma non
ascoltò i contadini e i briganti.
Risultato pratico della commissione fu la
promulgazione nel 1863 della legge Pica, che assegnava ai tribunali militari un
ruolo decisivo ed annullava nei fatti qualsiasi forma di Stato di diritto.
«Non è in discussione – scrive Panarese – il
processo unitario, l’esito finale delle lotte risorgimentali, ma il come è avvenuto quel processo, che non
ha costruito una nuova nazione, ma ha cristallizzato ed esasperato le “Due Italie”». Le ferite allora aperte
non si sono ancora rimarginate.
Rocco Biondi