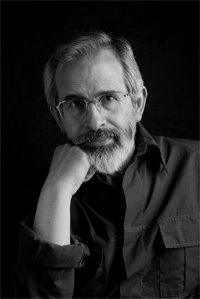Mario
Guagnano nell’introduzione e Pino Aprile nella prefazione offrono una lettura
meridionalista dei fatti avvenuti in Puglia e in particolare a Gioia del Colle,
in provincia di Bari, negli anni dal 1861 al 1863.
Pino Aprile inquadra gli avvenimenti
storici di quegli anni nel più generale movimento, cosiddetto Risorgimento, che
ritiene essere stato un bagno di sangue nascosto sotto cumuli di retorica. I
massacri perpetrati dai piemontesi e quelli dei briganti, scrive Pino Aprile,
non possono essere messi sullo stesso piano; la ferocia degli uni e degli altri
ha un’origine diversa: volendo i piemontesi opprimere e i briganti non essere
oppressi. Il Sud fu cancellato dalla storia; i valori di un terzo della
popolazione italiana furono calpestati e diffamati.
Mario Guagnano nella introduzione scrive
che il grande brigantaggio fu indotto da una serie di errori commessi dal nuovo
governo sotto pressione delle alte gerarchie militari. Il primo fu quello di
sciogliere l’esercito borbonico, con il successivo provvedimento di chiamata
alle armi, per vestire la nuova divisa dell’esercito sabaudo. Il secondo errore
fu quello di sciogliere nel gennaio del 1861 il comando generale dei volontari
garibaldini di stanza a Napoli che poteva contare su una forza di 76.000 uomini
di cui oltre i due terzi provenienti dalle regioni meridionali.
Molti dei soldati sbandati dell’uno e
dell’altro esercito, per sopravvivere, imbracciarono le armi e si nascosero nei
boschi, dando vita a molte bande armate. In quasi tutti i paesi del Sud le
popolazioni inalberavano i vessilli borbonici e inneggiavano per il sovrano
decaduto.
Per i piemontesi il brigantaggio divenne un
incubo. L’impiego di 120.000 uomini del giovane esercito fu il riconoscimento
implicito dell’importanza politica e militare del brigantaggio, in contrasto
con la propaganda ufficiale che dinanzi all’opinione pubblica interna ed estera
ne sottolineava i soli aspetti episodici e ladronecci, scrive ancora Guagnano.
Il nuovo governo unitario alla reazione del
Sud rispose con le fucilazioni di massa, operate soprattutto nei confronti
degli individui appartenenti alle classi più umili.
In questo contesto si svilupparono i fatti
che culminarono con il massacro del 28 luglio 1861 a Gioia del Colle. Già nel
dicembre 1860 a Santeramo, in provincia di Bari e che dista da Gioia una
quindicina di chilometri, vi era stata una rivolta, capitanata dall’ex sergente
borbonico Giuseppe Perniola, al grido di “Viva Francesco II”, alla quale
avevano preso parte circa quattromila persone, tra uomini e donne di tutte le
età, armate di fucili, falcioni, scuri e mazze, allo sventolio di bandiere
bianche borboniche. I Nazionali piemontesi intervennero con due cannoni, che misero
in fuga i rivoltosi. Seguirono molte perquisizioni ed arresti dei rivoltosi. A
queste operazioni intervenne, con molti uomini, la Guardia Nazionale di Gioia
del Colle.
Intanto in quest’ultimo paese si era
formato un Comitato borbonico, forte di circa settecento adesioni, che nominò
Comandante generale l’ex sergente e alfiere borbonico Pasquale Romano. Attorno
a lui si riunirono soldati sbandati dell’ex esercito borbonico e renitenti alla
leva voluta dai piemontesi, raggiungendo circa duecento uomini.
La scintilla che fece scoppiare i tragici
fatti di Gioia fu l’uccisione da parte di quattro briganti, dopo un diverbio e
una colluttazione, del caporale della Guardia Nazionale di Gioia Teodorico
Prisciantelli. Il sergente Romano non approvò. I nazionali risposero con
perquisizioni, arresti e un grande concentramento di guardie e di militi per
andare all’assalto dei briganti del Romano. Questi fu costretto ad assecondare
la volontà della maggioranza della sua comitiva di andare all’assalto di Gioia.
L’avvicinamento al paese da parte dei
rivoltosi avvenne intorno alle dieci del 28 luglio. Le prime case assediate
furono quelle poste nell’immediata periferia del paese, con l’assalto ai borghi
San Vito e Pignatari. Drappi bianchi sventolavano per le strade, molti
cittadini si erano aggregati agli assalitori, e si urlava: “Viva Francesco II,
abbasso Vittorio Emanuele”. Furono uccisi diversi uomini di fede liberale. Il
rancore serbato da alcuni popolani, scrive Guagnano, contro i militi della
Guardia Nazionale per gli arresti dei loro congiunti effettuati nei giorni
precedenti aveva acceso un odio incontrollato. Fu occupato l’intero borgo San
Vito popolato da circa tremila persone. Il predominio dei rivoltosi fu fermato
da un colpo d’artiglieria sparato a mitraglia. Rimasero a terra morti e feriti.
I rivoltosi tentavano di uscire dal borgo respinti però da un fuoco di
sbarramento. Il conflitto andò avanti per diverse ore, ma verso le tre
pomeridiane la situazione prese una svolta a favore dei nazionali. Iniziarono
le esecuzioni sommarie dei rivoltosi, che raggiunti dai militari venivano
uccisi sul posto.
Difficile, scrive ancora Guagnano,
tracciare un bilancio preciso delle vittime e descrivere le esecuzioni compiute
dai Nazionali per l’unilateralità dei rapporti e resoconti stesi dalle autorità
che riferivano con dovizia le crudeltà compiute dai rivoltosi, occultando
invece la feroce repressione operata.
Molti arresti furono eseguiti anche nei giorni
successivi alla rivolta. Il Sergente Romano riuscì a sfuggire alla cattura.
La parte seconda del libro parla della
breve vita del sergente Romano e del Brigantaggio politico in Puglia. Pasquale
Romano era nato a Gioia del Colle il 24 settembre 1833, da genitori poveri:
pastore il padre e filatrice la madre. Giovanissimo si arruolò nell’esercito
borbonico, rimanendo in quei ranghi militari per un decennio, ottenendo la
nomina a primo Sergente e il titolo di Alfiere. Dopo la smobilitazione
dell’esercito napoletano, ritornato a Gioia, fu nominato dal locale comitato
borbonico Comandante Generale delle squadre insorgenti di Gioia.
Successivamente, nell’agosto del 1862, in
una grande grotta del bosco Pianelle nel territorio di Martina Franca (Ta),
ottenne il comando supremo delle bande brigantesche pugliesi. A nominarlo
furono i condottieri Cosimo Mazzeo detto Pizzichicchio, Giuseppe Valente detto
Nenna Nenna, Giuseppe Nicola Laveneziana detto Figlio del Re, Antonio Locaso
detto il Capraro, Antonio Testino detto il Caporale, Scipione De Palo detto la
Sfacciatella, Tito Trinchera detto Titta, Rocco Chirichigno detto Coppolone,
Francesco Monaco.
Il Romano operò dal 1861 al gennaio 1863.
Sotto il suo comando le bande brigantesche ottennero vittorie e sconfitte.
Vinsero a Santeramo, Gioia, Castellaneta, Mottola, Noci, Putignano,
Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Cellino San Marco, Grottaglie,
Carovigno, Erchie. Uno dei principali fattori di vantaggio per le bande a
cavallo fu la loro eccezionale mobilità. Il modo di combattere contro la forza
regolare era quello tipico della guerriglia. Esperti dei luoghi, i briganti
prediligevano campi di battaglia dove in caso di insuccesso fosse possibile una
sicura e rapida ritirata.
Una delle più gravi sconfitte subite dai
briganti avvenne il primo dicembre 1862 presso la masseria Monaci di San
Domenico, posta tra i territori di Noci e Mottola. La disfatta della masseria
Monaci segnò la fine della condotta unitaria delle bande pugliesi. Le varie
comitive di briganti si ritirarono ognuna nel suo territorio di provenienza. Il
sergente Romano, ridimensionato nel suo prestigio, riorganizzò la sua comitiva
con quarantadue uomini e attaccò i nazionali in vari luoghi.
L’epilogo del Sergente Romano avvenne il 5
gennaio 1863 presso il Parco della Corte, nel bosco Vallata nei pressi di Gioia
del Colle, dove si era appostato con una quarantina di uomini. I nazionali
assaltarono la comitiva del sergente. Il bilancio ufficiale dell’operazione
parla di ventidue briganti uccisi e di venti che riuscirono a fuggire. Fra gli
uccisi vi fu anche Pasquale Romano, il cui cadavere fu legato sul dorso di un
asino e portato in segno di vittoria a Gioia. I resti del sergente, dicono le
cronache, furono meta di un pellegrinaggio di gente comune e dei sostenitori
del partito filoborbonico.
Il libro si chiude con le cronache della
fine dei più importanti gregari del Sergente e con alcuni cenni sulla relazione
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul brigantaggio, con riferimenti al
Sergente Romano e alla città di Gioia.
Rocco Biondi